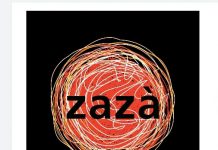In Caulonia, come in gran parte dei centri del sud, l’allegra stagione che si riconosceva sotto l’insegna dell’originale battuta ” semel in anno licet insanire!” comprendeva un arco di tempo di appena dieci giorni.
Tale ricorrenza andava dal decimo giorno a quello precedente il mercoledì delle ceneri.
Domenica, inizio del carnevale vedeva “tale giorno…interamente dedicato alle rappresentazioni farsesche (parti). Il primo spettacolo fatto da uno dei tanti gruppi di ‘mascherati’, molto spesso in antagonismo tra loro, aveva inizio verso le sette – otto del mattino, orario che coincideva con l’uscita della prima messa.
Dopo di ché codesti attori, improvvisatisi tali, tra canti, salti e a suon di musica, si spostavano per fermarsi nuovamente in qualche piazza, o crocicchio, ovunque vi fosse un discreto numero di persone disposte ad assistere alle rappresentazioni. Tutto ciò durava ininterrottamente sino a mezzogiorno per poi riprendere alle prime ore del pomeriggio…” (M. Cannizzaro)
Tra una recita e l’altra ci si muoveva per raggiungere un nuovo slargo e ciò avveniva cantando sempre lo stesso motivo con un testo dall’evidente doppio senso:
“La strada nel bosco
né lunga, né larga, né stretta
è fatta a barchetta
è fatta per fare l’amor.
L’amore lo faccio
lo faccio con la mia bella
che sembra una stella
una stella caduta dal cielo.
Caduta dal cielo
mandata, mandata da Dio
perché è l’amor mio
la voglio, la voglio sposare.
Sposarla non posso
baciarla, baciarla nemmeno
le dono il veleno
così la faccio morire.
La faccio morire
perché non può essere mia
e la sorte mia
sarà sempre, sempre soffrir.
Soffrir non voglio
godere, godere nemmeno
anch’io prendo il veleno
e la faccio finita così.”
Canzone licenziosa e di origine molto antica, veniva cantata già nel tardo medioevo da pellegrini che si recavano al santuario di S. Iacopo di Compostella.
Il testo giunto a noi sembrerebbe incompleto se ad esso O. Di Landro non avesse aggiunto una sua strofa conclusiva.
Attratti dal suono e dal canto numerosi erano i cauloniesi che si sistemavano “a ruota” intorno ai loro beniamini e ciascuno si disponeva a seguire tale genere di teatro popolare detto “a parti di mascherati” o come ancora oggi, viene definito, nei centri vicino a noi, “a rota”.
Era sempre il prologo, o meglio l’“avanti-prolugu” ad entrare per primo ed egli, impostando la voce, su una serie di divertenti endecasillabi sapeva attirare l’attenzione su un fatto che nel gaio e nel licenzioso sollazzo riusciva a sfociare in una sorta di satira.
Si! L’uso di satireggiare sui costumi durante il periodo carnevalesco si riscontrava anche a Caulonia.
La prima domenica di Carnevale, così il Giovedì e la seconda Domenica, e parte del Martedì, si era soliti rappresentare le “parti di mascherati”, che avevano come fine quello di ridicolizzare sia coloro che appartenevano ai ceti più popolari, sia in forma molto controllata persone appartenenti alla borghesia locale.
Tutto ciò è avvalorato dalla analisi del materiale farsesco di cui siamo venuti in possesso; materiale, questo, risalente alla prima metà del ‘900, periodo dopo il quale anche da noi cessò la produzione di farse.
Le <parti> sono frutto di lontane tradizioni, ma il loro testo di anno in anno, poteva subire delle modifiche a seconda che si prendessero di mira avvenimenti particolari successi nel corso dell’anno.
Codeste farse potevano essere quindi delle rappresentazioni di vita pubblica e privata del paese e svolgevano una funzione di controllo sociale analoga principalmente a quella svolta in altri paesi dal Testamento di Carnevale.
Nella produzione cauloniese e in particolare modo nel primo cinquantennio del ventesimo secolo, difficilmente vi era l’elemento politico.
Nel caso contrario era presentato, per lo più, molto evasivamente e sempre a favore della classe dominante.
D’altronde molte delle farse giunte fino a noi erano state prodotte durante il ventennio fascista, periodo durante il quale si era sottoposti ad una certa censura. Ci troviamo dunque di fronte a prodotti folclorici che appartengono a quel livello di contestazione immediata con accettazione dello <status quo>, intendendo per contestazione esplicantesi da <<… qualsiasi prodotto culturale che si contrapponga ad altro con la sua sola presenza>> (L.Lombardi Satriani).
E’ inoltre da sottolineare che spesso alla stesura dei testi farseschi vi contribuivano attivamente “signori” locali i quali, pur avendo rivali nella loro classe, mai avrebbero scritto tale genere di satira per indirizzarla contro quest’ultimi, avendo essi la consapevolezza che le loro creazioni sarebbero andate ad accrescere il patrimonio culturale popolare e non sarebbe stato certo nel loro interesse alimentare nel popolo scintille di ribellione.
D’altronde il carnevale è per il mondo cittadino e popolare, un viaggio in uno spazio ideale, una “emigrazione simbolica” che consente per un breve periodo dell’anno la sospensione rituale della quotidianità, il rovesciamento dei ruoli sociali o comunque l’attenuazione di alcune norme sociali, un momento di evasione che garantisse poi l’assetto e il mantenimento dello “status quo”.
Le invettive dei “signori” erano puntate, dunque, in queste occasioni, esclusivamente contro coloro che desideravano o avrebbero potuto desiderare il ribaltamento dei ruoli sociali.
La cultura popolare è stata sempre strumentalizzata dalla classe dominante al fine di soffocare qualsiasi impulso alla lotta, assicurando così ai dominatori il poter esercitare il loro dominio.
Le <parti> che siamo riusciti a recuperare si limitano ad un numero di cinque.
In un primo momento, ci è sembrato che molti nostri concittadini fossero in possesso di parecchi testi, ma poi è risultato, nella maggioranza dei casi, che si trattava di pochi frammenti scritti o ricordati a memoria.
In effetti nessuno si è mai assunto il compito di conservare nel tempo tutto questo patrimonio culturale irrimediabilmente perduto.
Questo dato di fatto purtroppo, ci dà una visione parziale dell’oggetto in esame.
Le cinque farse, come si è già detto, sono da datare nella prima metà del Novecento e solo di una si conosce l’autore; esse fanno parte di quella produzione strutturata in monologhi, dialoghi e canti con accompagnamenti musicali (chitarra, armonica a bocca, fisarmonica).
In genere nelle <parti> il verso maggiormente usato era l’endecasillabo, verso che permetteva, all’atto del recitare, di partire con una forte accentuazione della voce per poi scendere con l’abbassamento del tono, quindi risalire e ad un attento ascolto era possibile riconoscere il ritmo della nostra parlata (parlata cadenzata), pur se in forma esagerata.
I versi destinati al canto erano ottonari, i più musicali della metrica italiana.
Il fatto che il “fidanzamento”, con conseguente matrimonio fosse l’argomento preferito, avvicina le nostre farse al <bruscello> toscano e all’antico uso di annunciare il fidanzamento a scopo propiziatorio in occasione del carnevale. Per tradizione i personaggi delle <parti> cauloniesi erano interpretate da uomini; alle donne era sconveniente partecipare attivamente a queste rappresentazioni, ma in questi casi si trattava sempre di donne di facili costumi.
I <Mascarati> delle nostre farse non adoperavano mai le maschere, recitavano a viso scoperto.
Gli interpreti dei personaggi maschili erano soliti dipingersi il viso con dei tappi di sughero bruciato, con i quali accentuavano di nero le sopracciglia, le basette e, con la stessa tecnica, si dipingevano baffi e barba.
I <mascarati>, in genere, avevano la testa ricoperta da finti capelli di stoppa e gli abiti che indossavano servivano a farne riconoscere a prima vista dagli spettatori il grado, e possibilmente il carattere dei personaggi.
Anche i personaggi femminili si presentavano con il viso truccato: gli zigomi avevano due pomelli rossi e le labbra erano dipinte dello stesso colore.
Per questa operazione, si adoperava la carta velina rossa, in seguito si preferì il rossetto.
Sulle guance appariva sempre dipinto qualche grosso neo.
Pure in questo caso era la stoppa a dare l’idea dei capelli, mentre la testa poteva essere coperta da un fazzolettino o da un cappellino, a seconda che il personaggio rappresentasse una contadina o una donna della borghesia.
Ci siamo chiesti il perché dell’uso costante della parrucca di stoppa e per le maschere femminili e per quelle maschili.
Se i “mascarati” avessero usato la maschera si sarebbe potuto supporre che la parrucca fosse stata uno degli accessori adoperati ai fini di celare i loro connotati somatici.
Se invece fosse stata usata esclusivamente dai personaggi femminili, ed essendo costoro interpretati da soli uomini, il motivo sarebbe potuto essere questo: l’imitazione dei capelli lunghi da donna.
Per cui è da pensare che essa non fosse se non il misero riadattamento della raffinata parrucca settecentesca.
La stoppa, dunque, unitamente all’uso del neo, del quale abbiamo anche fatto cenno, potrebbe essere uno degli infiniti esempi di prodotti o modelli della cultura egemone che sono passati successivamente a quella popolare.
Continuando il nostro discorso sui <mascarati>, è ancora da dire che gli attributi muliebri nelle corrispondenti maschere erano molto evidenziati; ciò potrebbe rispondere all’ideale femminile delle nostre classi popolari, secondo cui l’esser grasse e paffute equivaleva a bellezza ed era sinonimo di salute fisica, comprensibile questo in un ambiente dove un sano nutrimento era un grosso problema. Inoltre gli psicologi potrebbero vedere a riguardo appetiti sessuali repressi tipici di classi legate a certi valori morali e religiosi.
I <mascarati> avevano un modo vistoso di recitare: grande uso facevano delle braccia, con particolare mobilità degli avambracci e delle mani, che muovevano con ampi gesti, insieme al tronco e agli arti inferiori, che piegavano ad elastiche movenze.
La mimica facciale buffonesca è di una espressività tutta esteriore (l’espressività interiorizzata appartiene al genere di teatro psicologico); per cui il riso ed il pianto, esplicazione dei due stati d’animo essenziali nelle forme elementari di teatro, erano simulati attraverso ampie smorfie ed accompagnati da un tono sguaiato della voce.
Ci troviamo così di fronte ad un “teatro gestuale”, tipico della cultura popolare.
Infatti, la borghesia ha, per motivi di cultura, a mano a mano ridotto nel tempo la gestualità, da noi intesa come linguaggio del corpo, concentrando tale linguaggio, alla testa.
Nei ceti popolari, invece, tuttora si continua, ai fini del comunicare, ad accompagnare, e spesso a sostituire, la parola al movimento di tutto il corpo il cui codice cinesico varia all’interno di detti gruppi a seconda delle aree culturali alle quali essi appartengono.
Così ad un certo tipo di dialetto, ad esempio, si accompagneranno dei movimenti tipici.
Inoltre, quando al quotidiano bisogno di comunicare si aggiunge quello di fare teatro, il gesto diventa più plateale ed enfatico, sia perché esso è legato a momenti più intensi di comunicazione sociale, nel qual caso, i gesti aperti (braccia allungate in avanti) prevarranno su quelli chiusi e più riservati (braccia conserte), sia perché non secondaria è la necessità di portare tale rappresentazione ad un grado di visibilità per tutti, in quanto essa si esplica davanti ad un pubblico posto quasi sempre sullo stesso piano di quello sul quale recitano gli attori.
I personaggi ricorrenti nelle parti, oltre a quelli dell’Avanti-Prolugu, du ‘zzitu e da ‘zzita, du massaru e da massara, du parracu, du notaru, du medicu e du sindacu erano a Zà-vecchja e suo figlio Carnilavari o ‘Ntoni.
Queste due ultime figure, che nell’ultimo giorno di carnevale erano protagoniste, nelle farse, al contrario, non avevano in genere i ruoli principali, anche se svolgevano una azione drammatica decisiva per lo sviluppo e l’epilogo della trama.
E’ da notare che figure equivalenti a quella della Zavecchja sono presenti in quasi tutte le regioni d’Italia: nel Veneto vi è la Vecja; in Lombardia e così nelle Marche la Vecchia; in Romagna la Segavecchia, in Sicilia la Nanna.
Tutte costoro, in forma semplice o elaborata, in conformità alle tradizioni alle quali appartengono, danno luogo, l’ultimo giorno di Carnevale, per il contrasto nascente tra esse e il personaggio <Carnevale>, ad una forma drammatica che culmina con l’eliminazione di Carnevale e che trova le sue origini nel Medioevo e, nel Rinascimento, giunge a trasformarsi in genere letterario, coltivato da cantastorie e poeti d’arte.
Gli studiosi riconoscono in tutte queste figure femminili lo stesso simbolo: la Quaresima. Questo simbolo e quello del carnevale, in tempi a noi lontani, dovevano rappresentare l’anno vecchio e l’anno nuovo oppure l’inverno e la primavera. Personaggi simbolici, dunque, di riti agrari e propiziatori che si sono deformati nel tempo a contatto dei nuovi valori conseguenti all’adattamento della festa carnevalesca alla religione cristiana.
Un cenno particolare merita anche il Prologo, che da noi veniva denominato <Avanti – Prolugu>.
Non si sa bene il perché di questo <Avanti>.
È probabile che la folla degli spettatori, desiderosa di assistere alla farsa, incitava i <mascarati> a che dessero inizio allo spettacolo chiamando in scena il Prologo al grido di <Avanti – Prolugu!>, ossia: <vieni avanti Prologo!>.
Detto personaggio era sempre vestito di bianco con il capo coperto con veli da sposa, mentre una striscia di carta stagnola argentata fungeva da corona; sempre una croce rossa era dipinta sulla fronte e sulle guance i soliti pomelli rossi; in mano un bastoncino a mo’ di scettro. Simboli tutti questi di cui si è persa la comprensione del significato; ma tenendo presente che nel teatro classico il prologo poteva essere una divinità, trasformatasi in angelo in quello religioso, è possibile pensare che sia giunto nel teatro popolare in un misto di sacro – cristiano e precristiano.
La <parte> dei <mascarati> veniva presentata oltre che nella prima domenica di Carnevale, il successivo Giovedì detto Grasso, la seconda Domenica, mentre l’ultimo giorno di carnevale, <Marti i lazzata>, le <parti> occupavano poco spazio.
Esse venivano svolte sino alle prime ore del pomeriggio, dopo di che tutto il tempo era dedicato alle varie rappresentazioni della morte di <‘Ntoni> o di <Carnalivari>, dovuta al troppo mangiare, che più gruppi di “mascarati” svolgevano indipendentemente gli uni dagli altri.
Dette rappresentazioni si dividevano in due scene essenziali: il trasporto funebre con relativo pianto, e l’eliminazione di <‘Ntoni>.
Ogni gruppo di mascherati conduceva, per suo conto, “Carnilivari” (che il più delle volte era una persona in carne ed ossa travestita, e più raramente una pianta di ficodindia rivestita con gli abiti tradizionali di ” ‘Ntoni”) per le vie del paese, simulando nei minimi particolari la cerimonia di un trasporto funebre.
Ogni corteo era aperto da un uomo recante una croce che, al posto dei simboli della passione, aveva affissi, in quella occasione, delle ossa di carne di maiale, che testimoniavano la grande abbuffata di ‘Ntoni.
Il portatore di croce aveva indosso l’abito che gli appartenenti (fratelli) delle arciconfraternite cauloniesi usano tuttora nelle cerimonie religiose, e in particolare nei funerali (un camice lungo e bianco col cappuccio, una mozzetta di velluto ed un cordone rosso alla vita).
Tutto il corteo seguiva la bara, (di solito una scala di legno, il cui scheletro era imbottito per contenere comodamente il corpo di ‘Ntoni) sorretta a braccio da quattro fratelli, mentre ‘Ntoni, steso di sopra, era immerso tra tante ossa di maiale. lI carnevale morente era contenuto in una tuta da lavoro imbottiva di cuscini e stracci, perché fosse evidente il ventre rigonfio per il troppo mangiare e bere.
“Carnalavari…straccione, sbracalatu, unto e bisunto, ingozzato di grascia e avvinazzato, motteggiatore salace sguaiatamente becero – rappresenta – allegoricamente! – la miseria endemica e atavica della plebe bracciantile diseredata e lupescapente, insaziabilmente affamata, che solo attraverso l’abbuffata carnevalesca soddisfa – precariamente – l’antico desiderio – insaturabile! – di sfamarsi, seda – momentaneamente! – la brama inappagata di satollarsi.” (G. Falcone)
‘Ntoni aveva sempre in mano un campanaccio che dimenava sino a poco prima di morire, il suo viso era celato da stoppa, mentre dalle brache aperte fuoriusciva, dopo essere stato opportunamente essiccato, un budello rigonfio di maiale, simbolo fallico, espressione di fertilità per feste che come queste trovavano le loro origini nei riti propiziatori.
Poi seguiva il personaggio della <Zà-vecchjia>(madre di ‘Ntoni) attorniato da un nugolo di “mascarati” che avevano ottenuto il loro travestimento con l’associare disordinatamente e nel modo più assurdo indumenti ed oggetti vari.
La madre di ‘Ntoni, (dietro la bara era possibile trovare il personaggio della Zà-vecchjia moltiplicato in più persone), tutta vestita in nero, aveva indosso due lunghe gonne (saija) una sull’altra; quella esterna tirata all’insù sino al capo serviva a coprire l’intero busto ed in fronte s’intravedeva tra il nero della gonna, a mo’ di manto, una fascia bianca.
Camminava la Zà-vecchjia ricurva su di un bastone, lamentandosi vistosamente per la morte imminente del figlio e rivolgendosi a questi con le parole: <Ntoni, Ntoni me fighju, ti li mangiasti tutti li pruppuni>, mentre gli altri mascherati gridando al par di essa, le facevano, in atteggiamento tragicomico, da sostegno morale.
Ogni corteo, in un caratteristico gestire e procedere, si muoveva tra urli e pianti a ritmo di qualche chitarra, fisarmonica e tamburino, che scandivano un triste ritornello con monotona e seria comicità.
I vari funerali, girando per le vie si soffermavano sulle piazze da dove i <mascarati>, torcendosi e saltando sguaiatamente, ritornavano indietro ridiscendendo le vie senza stancarsi mai. Molti dei componenti i cortei funebri avevano in mano una bottiglia di vino alla quale, e con avidità, ricorrevano spesso: non tutti i giorni si aveva la possibilità di bere così generosamente.
Allorquando uno di loro passava davanti alla casa di un amico, veniva assieme al gruppo invitato ad entrarvi, compreso magari Ntoni che abbandonava volentieri per qualche minuto la sua bara.
La casa amica offriva, alla brigata, vino da pasteggiare con carne di maiale ucciso, per l’appunto, nei giorni precedenti, e “pruppetti”.
Al sopraggiungere della mezzanotte quasi tutti erano completamente ubriachi, i vari ‘Ntoni morivano ed il loro corpo, che nel frattempo era stato sostituito con un fantoccio, veniva gettato da un burrone mentre il campanone della chiesa, nell’avvertire che il carnevale era finito ed ormai era tempo di quaresima, richiamava all’ordine.
Questa scena ultima poneva fine alla sequela delle varie azioni drammatiche del carnevale.
‘Ntoni, morendo, portava via con sé tutto ciò che era vecchio, che era malattia, peccato.
Le feste carnevalesche, tradizioni sincretisticocristiane dei riti di fertilità per un nuovo ciclo d’anno, hanno così, pur se le coscienze sono ormai lontane da questa comprensione, purificato la collettività che poteva guardare al tempo venturo con ottimismo.
Morto ” ‘Ntoni”, eliminati i vari “carnalivari”, ogni buon cauloniese, risciacquando più volte con acqua calda e cenere l’intera sua cavità orale, provvedeva a fa sì che nessun residuo di carne rimanesse in qualche interstizio dentario una volta scoccata la mezzanotte.
Non era possibile “cammaràrsi”, cibarsi di carne nel lungo periodo quaresimale.
Il devoto contadino non ammetteva “impurità” in quella parte dell’anno e così piano piano si scivolava verso un’altra storia.
Tratto da “Periodo di Carnevale a Caulonia” di Teresa Giamba e Gustavo Cannizzaro